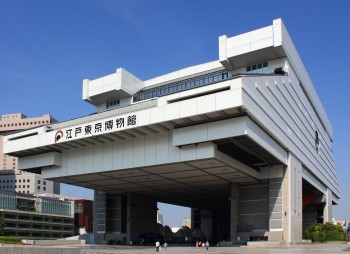-
.
Innanzitutto, seppur conscia del tremendo ritardo, faccio i miei migliori auguri di Buon Compleanno alla cara Ely, Kezia e tutte coloro che mi sono persa. Tanti auguri!!  Perdonate il tempismo.
Perdonate il tempismo. 
***
Sono invece ancora in tempo per rivolgermi alla festeggiata di oggi. Detto questo... Tanti auguri Giallo,
Tanti auguri Giallo, 
 Buon Compleanno!
Buon Compleanno! 
-
.
Con la dolcezza della sua melodia e la bellezza delle sue parole, questo brano ha la capacitá di emozionarmi ogni volta che lo ascolto.
La versione di questo concorrente, poi, l'ho apprezzata davvero di cuore. -
.
Stasera ho visto Your Name.
Volevo ringraziarvi. Per averne parlato, per i vostri commenti e per avermi permesso di cogliere questa nuova occasione ed avere quindi modo di ammirarlo.
Mi ha colpito ed incredibilmente emozionato.
Grazie ancora. -
.
Risposta esatta!!
Brava anica!


A te la parola.
-
.
No, non si tratta della Tsuki.
Se risulta troppo difficile, vi fornisco un aiutino.
Come aveva giustamente intuito Anica, questa citazione é stata tratta da una rappresentazione... -
.
No Anica, non è questo il contesto... -
.
Grazie! 
Dunque... Vado a prendere i volumetti e vi cerco subito una frase. Portate un attimo di pazienza, per favore.
Eccomi di ritorno.
Spero che la citazione da me scelta non sia stata utilizzata di recente. Non seguo il gioco da un po' di tempo...Ho paura...
Ho paura di venire separata da lei...
Quando il passato che dorme sarà stato risvegliato...
...mi separerá da lei...! -
.
Posso provarci anch'io?
A me torna in mente Maya nei panni di Ardis durante la prima de "Le due regine".
Nel mezzo della rappresentazione... Ayumi in scena nei panni di Oligerd é sempre più convincente... Maya che attende il suo ingresso dietro il sipario, finalmente comincia a lasciar andare la tensione dettata dal dover essere all'altezza della sua rivale. Non le importa più. Da adesso ció che importa è Ardis, lei, le sue emozioni e nient'altro... -
.
Care forumine, vecchie e nuove, auguro ad ognuna di voi una felice conclusione di questo 2016 che è ormai arrivato al suo termine.
Si volta pagina, dunque, sperando che questo nuovo anno sia migliore di quello passato.
Ho imparato che serenità e salute sono le cose che più contano veramente e sono quelle che auspico a tutte voi.
Buon Anno, forumine.
-
.
Sembra quasi finto... una visione che cattura il cuore dello spettatore con la lucentezza dei suoi colori e quell'atmosfera quasi onirica che lo permea.
Un'immagine che parrebbe appartenere solo al mondo dei sogni, ma che corrisponde invece alla realtà.
E' stato ribattezzato "Lo stagno di Monet" e non è difficile capire il perché.
-
.
Wow! Sembrerà stupido ma, sebbene sia sempre stata curiosa di assistere a questa “cerimonia”, non ho mai pensato di cercare un video per osservare la vestizione del kimono (sono proprio tonta a volte, lo so  ).
).
Per questo, grazie Arlaune. Ho apprezzato davvero molto l’idea di aprire questo topic.
A riguardo, qualche tempo fa ho avuto modo di leggere un articolo su quest’abito tradizionale. Io l’ho trovato molto interessante. Alcuni dettagli sono già stati citati nel primo video da te postato, ma se vi può far piacere, ve lo riporto volentieri.**********
Il kimono… è l’esatto opposto di qualunque idea di funzionalità; è tanto costoso quanto scomodo; rappresenta la rigidità della virtù, dell’ordine, della modestia, ossia quanto di più indigeribile per una donna che voglia essere (e alla quale venga chiesto di essere) moderna, attiva, propositiva. Eppure in pieno XXI secolo, sono assai poche le ragazze giapponesi che non abbiano mai indossato o desiderato indossare un kimono; ancora meno sono le mamme il cui sogno non sia di vedere la figlia avvolta da un frusciante e sgargiante furisode, il kimono per le giovani “da marito”.
Tutte d’accordo, le signore, anche nell’affermare che un uomo in kimono è più bello e interessante di un uomo in jeans.
Insomma, il kimono è tutt’altro che morto, anche se le donne oggi vogliono accavallare le gambe e gli uomini non sono più samurai.
Nulla a che vedere con i “costumi tipici” che da noi vengono esibiti a uso dei turisti.
Ci sono certi momenti, alcune scadenze precise, in cui il kimono affiora e si impone: la presentazione al tempio, la laurea, il matrimonio, i funerali, la morte. Tutto inquadrato in un intrico di regole tanto numerose quanto sottili: gli sbagli sono per chiunque sempre in agguato. Tanto più lo sono oggi, dato che il kimono rappresenta uno strappo alla quotidianità.
Ecco perché continuano a fiorire le accademie – coadiuvate dai più moderni sistemi di insegnamento – per chi voglia imparare il corretto portamento, il più idoneo accostamento di colori, il modo di vestirsi, già di per sé una specie di cerimonia che dura almeno un’ora, e perfino come ripiegare l’abito.
Quello che viene insegnato è il kimonese, una lingua senza suoni ma con una straordinaria molteplicità di significati e di sottintesi.
Nulla di straordinario: a qualunque latitudine e in qualunque civiltà, l’abbigliamento ha un apparato simbolico, importante quanto la concreta necessità di ripararsi dal freddo o soddisfare il pudore. Ma il cammino parallelo di wafuku e yofuku, gli abiti tradizionali e quelli di foggia occidentale, ha creato in Giappone una duplicità di codici che richiede ripassi, specie per evitare che la grammatica e la sintassi di una lingua si riversino in modo cacofonico nell’altra.
Che poi a questi due mondi, rigidamente separati, se ne possa aggiungere in futuro un terzo, fatto di casuali o volute contaminazioni, resta un interrogativo tutto da sciogliere.
Intanto qualcosa si muove. Nei matrimoni, l’occasione più ghiotta per sposi e invitati di vestirsi secondo tradizione, il tipico abito da sposa occidentale sostituisce sempre più spesso il kimono candido, anche se poi la sposa correrà a cambiarsi subito dopo la celebrazione per indossare il suo ultimo furisode e poi ancora il suo primo tomesode a sfondo nero da signora.
Anche lo yukata, il più semplice, leggero ed economico abito che rientra nella categoria dei kimono, sta guadagnando terreno.
Nelle stazioni termali è normale passeggiare indossandolo, ma ormai anche nelle grandi città si vedono giovani coppie, in estate, andare in giro con lo yukata. Si fanno anche ardite fusioni stilistiche, come calzare scarpe coi tacchi anziché i canonici geta di legno o gli zori di cuio rivestiti di stoffa.
Questa avanzata dello yukata è davvero innovativa perché nella rigida divisione tra wafuku e yofuku , cominciata intorno al 1880, l’unico tipo di abito “giapponese” salvato dal vortice della modernità occidentalizzante è stato quello da cerimonia.
Non fu un caso, bensì una precisa scelta politica da cui il Giappone di oggi è ancora condizionato. Una scelta fatta da una classe dirigente di stretta ascendenza samurai, ma già proiettata verso quel nuovo tipo di economia e di organizzazione militare che avrebbe presto trionfato.
In questo senso il kimono costituiva e costituisce tutt’altro che una reliquia del passato, una sopravvivenza a metà strada tra il romantico e il patetico. E’ un preciso veicolo di stabilità sociale, il traino dell’apparato culturale che ancora nutre il nazionalismo nipponico. E secondo questo apparato lo yukata sta ai margini: indica il limite di informalità consentito.
In teoria non gli sarebbe permesso di suggerire il cambiamento.
La teoria, invece, accetta senza problemi la schizofrenia. Ha detto bene Liza Dalby, scrittrice, antropologa e soprattutto unica occidentale che sia davvero diventata una geisha: “La tattica vincente dell’establishment pro wafuku è sempre stata quella di incoraggiare le giovani donne a scoprire un nuovo sé nel kimono”. Un concetto così riassunto da un’inserzione pubblicitaria: “Cambiare abito dal profondo del proprio cuore” .
La voglia, la disponibilità, ci sarebbero. Quello che trattiene è semmai il costo proibitivo. E se la scelta, al momento della laurea o del raggiungimento della maggiore età, è tra un master all’estero o un furisode, anche il fascino del kimono vacilla.
In tutti i centri commerciali di Tokyo c’è un settore dedicato al kimono, ma di clienti se ne vedono pochi.
Seibu è uno dei più forniti. Il signor Mitani, capo delle vendite nella filiale di Ikebukuro, non sembra avere molto da fare e mostra orgoglioso i tagli di stoffa esposti. Ammette che difficilmente arriva a venderne due al giorno. Non è colpa della disaffezione verso tale indumento, ma della crisi.
Non vale la pena di avvicinarsi se si hanno meno di 5mila euro, ma per non fare figuracce ce ne vogliono almeno il doppio.
La stoffa – che tranne rare eccezioni è seta – è solo una voce della spesa complessiva, anche senza contare il lavoro di sartoria, limitato ad un assemblaggio secondo regole fisse.
Importante e costoso quanto l’abito è l’< i >obi, una fascia damascata lunga circa 4 metri e alta poco meno di 60 centimetri (indossata appare più bassa perché viene piegata a metà); e poi ci sono scarpe, borsetta, haori (giacca) o scialle, la veste da mettere sotto al kimono, che diventa visibile a livello del colletto. Né si può fare a meno di mille altri accessori, in particolare corde, cordicelle e fermagli, indispensabili per dare al vestito la lunghezza desiderata, 6 centimetri sopra i piedi, e tenere tutto al posto giusto.
Certamente oggi ben pochi possono permettersi di avere tanti kimono quanti ne richiederebbe l’etichetta.
A parte quelli “speciali” per i matrimoni e per i funerali, va valutata la formalità dell’evento cui si partecipa, ma soprattutto non si può sgarrare riguardo alla stagione in cui si indossa il kimono e l’età di chi lo porta.
Se non si vuole rendersi ridicoli, bisogna che in primavera il colore di fondo sia pallido e che non manchino i fiori di ciliegio; in inverno massima lucentezza e disegni di pino, bambù o fiori di susino; sfumature più scure e calde in autunno e così via.
I colori vivaci adatti alle ragazze devono poi lentamente scomparire fino a diventare molto sobri con l’età matura.
Cambia nel contempo la forma delle maniche: quelle per le nubili arrivano alla caviglia, mentre per le sposate sono di lunghezza normale.
E allora? Il gentile signor Mitani mostra il suo rimedio, un magnifico insieme di peonie, crisantemi e fiori di susino e ciliegio, insomma il classico vestito per tutte le stagioni.
Ma è chiaro che non basta. Più radicale è il rimedio offerto da un negozio proprio di fronte, che vende kimono usati anche a soli mille euro: funziona, visto che ne smercia 40 alla settimana, mi dicono.
Ancora più estremo è accontentarsi del kimono che un tempo era della madre e magari prima ancora della nonna. Tanto non vanno fuori moda, dice con un pizzico di dispiacere un altro responsabile delle vendite di kimono, questa volta in uno dei più lussuosi grandi magazzini di Shinjuku.
Dagli anni Venti, in pratica, colori e disegni ispirati alla natura (fiori in primo luogo, ma anche spesso uccelli) non cambiano. Al massimo variano le dimensioni. Quanto alla collocazione, è sempre la stessa, cioè sulla spalla destra e sull’ampio orlo inferiore, a meno che, come nei komon, il motivo non si ripeta su tutto il vestito.
Fanno affari i negozi che affittano abiti tradizionali: in tal caso bastano 3-400 euro e nel prezzo è compreso il parrucchiere; va da sé, infatti, che il kimono non può sopportare capelli lisci e dritti che cadano sulle spalle. Richiede acconciature complicate.
Il motivo, o almeno uno dei motivi, è che in tal modo può manifestarsi al massimo la carica erotica che il kimono racchiude. E’ una carica che proviene dal più profondo passato del Giappone e che emerge nelle stampe erotiche dell’ukiyo-e non meno che nell’abbigliamento di maiko e geisha.
Il messaggio è nella nuca, la cui bianchezza rifulge tra il nero dei capelli, tenuti in alto da spilloni e monili, e i colori della stoffa: pochi centimetri di pelle lasciati scoperti dalla parte posteriore del colletto, che va a formare una piccola curva. Pochi centimetri, ma decisivi – naturalmente se accompagnati da un giusto contorno di grazia e dignità – anche in un Giappone dove imperano tra le ragazze hot pants e microgonne.
Capolavori di arte grafica
Katsumi Yumioka colleziona kimono d’antiquariato, che vende nel suo negozio di Tokyo (che si chiama Ichinokura e si trova nel quartiere Shibuya).
Per realizzare questo volume, composto da 130 tavole, ha selezionato – privilegiando gli accostamenti di colore e i loro significati nella cultura giapponese – pezzi dal Seicento ai giorni nostri.
“Kimono. I colori del Giappone” di Katsumi Yumioka;
Ippocampo Edizioni, 25 Euro.
(tratto da “Meridiani”, anno XXIV, Febbraio 2011, n° 195) -
.

Chi di voi ha avuto modo di guardare, almeno una volta, il film “Memorie di una Geisha”?
Oltre alla figura della geisha e a tutto ciò che ne concerne, fa qui la sua apparizione, seppur brevemente, uno degli sport simbolo del Giappone: il Sumo.
Nel secondo disco del Dvd, viene spesa qualche parola in più a riguardo.
Qualora foste curiosi, però, di ricevere maggiori informazioni, ecco qui un articolo che ne approfondisce l’argomento.
Buona lettura.
**********
“Il popolo più longevo del mondo grazie ad una dieta povera di grassi, adora lottatori che vanno spesso incontro a morti premature a causa di un’insana dieta ingrassante, indispensabile per raggiungere le pachidermiche dimensioni richieste nel più antico sport del Giappone: il sumo.
Uno dei tanti aspetti contraddittori di una civiltà di cui continua a sfuggirci la piena comprensione.
La venerazione dei giapponesi per i campioni di sumo è da intendersi anche in senso letterale, perché la tradizione vuole che nel corpo dei grandi campioni alberghi un dio fino a che l’atleta non ritenga più opportuno e dignitoso ritirarsi. Solo allora il sacro inquilino lascerà il corpo del suo protetto. Ma se l’ex atleta decide di intraprendere la carriera di capo-scuderia, il dio tornerà istantaneamente nella sua colossale struttura per aiutarlo a condurre i suoi uomini al successo nell’intensa attività agonistica che vede impegnati ogni anno i migliori elementi delle oltre 50 heya ( famiglia-scuola-scuderia) in cui si suddividono i lottatori professionisti.
Le origini del sumo si fanno risalire al VI secolo dopo Cristo. Costumi, rituali, regole di comportamento scaturiscono dalla religione shinto, in cui si venerano circa otto milioni di dei.
I lottatori, chiamati rikishi o sumotori, sono classificati in diverse categorie. La più elevata è la Makuuchi.
I primi tornei di sumo per professionisti furono organizzati a Edo, oggi Tokyo, a cominciare dal 1623. Oggi sono sei i grandi tornei annuali: tre a Tokyo (in maggio, settembre e gennaio), gli altri a Osaka (marzo), Nagoya (luglio) e Fukuoka (novembre).
Ogni torneo (basho, che vuol dire luogo) inizia di domenica e dura due settimane. Ogni giorno ciascun lottatore incontra un avversario diverso.
Negli ultimi anni molti stranieri (mongoli, russi, hawaiani, bulgari, rumeni) hanno fatto irruzione con sorprendenti successi nel sumo, amareggiando non poco i fan giapponesi. Forse è da considerare una sorta di barriera divisoria tra i campioni nipponici e quelli stranieri la circoncisione a cui si dice debbano obbligatoriamente sottoporsi questi ultimi.
Attualmente, la scena è dominata dal mongolo Hakuho Sho, yokozuna (che vuol dire «ampia corda », perché il massimo campione entra sul ring portando una grande corda di canapa) dal 2007. Dietro di lui, sono in lotta per il secondo e terzo posto due suoi compatrioti: Asashoryu e Harumafuji. A tenere alto l’onore dei rikishi giapponesi, almeno nel ricordo, è Akebono, yokozuna dal 1993 al 2011, uno dei più grandi di tutti i tempi.
Sumo vuol dire strattonarsi. E gli atleti, in apparenza niente affatto preoccupati dalla stazza degli avversari che può sfiorare o eccedere i 200 chili, non si fanno pregare. Si afferrano per il caratteristico e necessariamente robusto perizoma (detto mawashi), unico loro indumento in combattimento, e si sbatacchiano di qua e di là, in giù e persino in su, in un balenio di lardo e muscoli, con esplosioni di incontenibile forza con raffiche di violente manate da uccidere un montone.
I colpi proibiti sono: infierire con le dita negli occhi dell’avversario, tirare i lunghi capelli raccolti in una sofisticata crocchia chiamata Oi-cho mage (che viene solamente recisa a fine carriera), sferrare calci al petto e allo stomaco, assestare colpi al basso ventre, piegare all’indietro le dita, colpire con il pugno chiuso, denudare l’avversario. Quest’ultima proibizione è relativamente recente e si ritiene che sia stata adottata in segno di rispetto dell’etica occidentale. Infatti sino al 1913 i rikishi si affrontavano in totale nudità. Ogni infrazione viene punita con la squalifica immediata.
L’incontro di sumo si svolge in un unico «round» all’interno di un cerchio di paglia (dohyo) con un diametro di circa 4,5 metri delineato in un quadrato di sabbia e terra sopraelevato di circa mezzo metro, circondato dalle tribune degli spettatori.
Nel cerchio vi sono due linee davanti alle quali si fronteggiano accosciati i rikishi, pronti allo scontro. Che può durare anche pochi secondi.
La vittoria può arridere in due modi: facendo toccare per terra una parte qualsiasi del corpo dell’avversario, o spingendo l’avversario fuori dal cerchio.
Non sono rare le vittorie ottenute sollevando l’avversario e proiettandolo fuori del dohyo. Per questa ragione, le prime file sono considerate pericolose e non adatte alle donne. In ogni caso, gli organizzatori dei tornei chiariscono per iscritto che nessuno spettatore ha diritto a qualsivoglia risarcimento se subisce danni fisici per collisioni con gli atleti scaraventati fuori dal ring.
Si arriva al momento dello scontro al termine di un lungo preludio che vede l’arbitro al centro del ring presentare con voce stentorea e solenne uno per uno tutti i concorrenti, invitandoli a schierarsi in circolo attorno al dohyo, rivolti verso il pubblico plaudente.
Nelle tribune non mancano le signore vestite di serici kimono e ragazze in ruvidi jeans. Queste ultime spesso lanciano gridolini isterici quando ritengono di essere riuscite ad avere una fulminea visione del pene di un lottatore il cui perizoma si è spostato leggermente nelle agitate fasi del combattimento. Si favoleggia che il membro sia proporzionato al corpo, cioè sproporzionato.
Le mosse (kimarite) del sumo, sono per antica tradizione 48. Si dividono in mosse di spinta, di traino, di proiezione e di sollevamento.
Vedere un lottatore di circa duecento chili sollevare un pari peso e gettarlo fuori dal ring come un sacco di patate, lascia senza fiato. Specialmente se il malcapitato perdente atterra con sconquasso a pochi centimetri dai piedi dello spettatore a cui un inflessibile bagarino ha sfilato 300 euro per un posto-ring.
L’incontro è diretto da un arbitro interno, detto gyoji e da diversi giudici laterali seduti su sedie a bordo-ring. Normalmente non ci sono dubbi su chi sia il vincitore, ma nei casi controversi i giudici laterali salgono sul ring e confabulano con l’arbitro interno fino a raggiungere un accordo unanime, senza il quale si deve ripetere l’incontro, perché il pareggio non esiste.
Una mossa preparatoria dell’incontro è lo shiko. l’alzata di una gamba tesa fino superare la testa e fatta ricadere con grande tonfo. Gli spettatori gridano «yoisho», sincronizzando «yoi» con il sollevamento della gamba e «sho» con il fragoroso ritorno dell’arto sul dohyo. Sono parole intraducibili di incitamento alla lotta.
Prima di slanciarsi l’un contro l’altro i contendenti si studiano per un massimo di quattro minuti, accovacciati, fissandosi negli occhi e cercando di scoraggiare l’avversario con un’espressione di forza. I lottatori fingono di essere sul punto di balzare contro l’avversario, e invece si alzano, fanno qualche passo come per rilassarsi, spargono una manciata di sale anti-iettatorio e si riaccucciano al loro posto pronti all’attacco: tecniche per innervosire e disorientare l’avversario.
Allo spettatore non giapponese può sfuggire l’attimo dello scatto che, spesso, coincide con la durata dell’incontro. Un buon consiglio per evitare questo sconcerto è di non perdere di vista i piedi dell’arbitro: finché sono paralleli si può stare tranquilli che i contendenti sono in fase di studio, ma non appena l’arbitro avanza il piede sinistro, scatta l’attacco. E’ come se spingesse un bottone di comando. Da segni invisibili a noi spettatori, l’arbitro «sa» che il momento dello scontro è arrivato.
L’arbitro interno veste un variopinto costume lungo fino alle caviglie, direttamente derivato dagli antichi parametri dei preti shintoisti, indumento ingombrante ma che non gli impedisce di schivare con abilità e movenze aggraziate le moli sobbalzanti dei contendenti senza smettere di incitarli alla lotta con grida stridule, sempre agitando freneticamente un ventaglio.
Il colore del ventaglio indica il rango dell’arbitro. Il massimo livello è tate gyoji (arbitro-capo) con ventaglio viola, o viola e bianco. La categoria immediatamente inferiore (San-Yaku) ha il ventaglio rosso.
Solo un tate gyoji può arbitrare un incontro in cui combatte uno yokozuna, un campione che ha vinto una serie di incontri ad alto livello, che non può essere retrocesso di categoria, ma se vince meno di otto incontri in un torneo, il codice etico del sumo richiede che abbandoni di sua volontà l’attività agonistica.
Un campione di sumo è su un gradino medio-alto nella scala sociale giapponese.
Se una ragazza annuncia di essere stata chiesta in sposa da un sumotori, è festa grande nella famiglia: benessere materiale e rispetto sociale sono assicurati. Non ci si aspetta nulla di più da un matrimonio. Un figlio, forse. Amore? Roba da manga.
Emergere nel sumo professionistico è molto difficile.
La vita dei giovani nelle heya è durissima, con frequenti punte di sadico bullismo.
Le reclute sono al servizio totale dei campioni. Debbono cucinargli speciali pasti ingrassanti e fortificanti della dieta chankonabe, sbrigare tutti i lavori domestici, fare da sparring partner negli allenamenti, il che vuol dire rassegnarsi a ricevere in silenzio terrificanti gragnole di colpi e dover poi esprimere anche sentimenti di gratitudine per la lezione ricevuta.
In un ambiente totalmente maschile, succede anche che i giovani siano indotti a prestazioni sessuali. Qualche anno fa un allievo fu ucciso da due lottatori per aver respinto le loro proposte.
La dieta è basata principalmente su pantagrueliche porzioni di un pastone di verdure, tofu, noodles e carne di pollo.
E perché non di manzo? Perché l’animale ha tutte e quattro le zampe a terra, una posizione troppo simile a quella del lottatore sconfitto. Insomma, porta sfiga.
Ogni torneo termina con la tradizionale danza con l’arco. Un allievo fa roteare con maestria l’arco a centro del dohyo lungo il cui perimetro sono schierati tutti i lottatori del torneo con variopinti grembiuli da cerimonia.
L’arco era il premio assegnato ai vincitori di un torneo nell’antichità. Oggi non è che un simbolo perché ai vincitori spettano «pesanti» borse offerte dagli sponsor e stipendi mensili faraonici assicurati dalle heya.
Al termine di ogni incontro, l’arbitro consegna nelle mani del vincitore una busta con il premio in danaro offerto dallo sponsor.
Anche i campioni di sumo, nonostante il dio che li abita, non sfuggono alla bramosia di accumulare ricchezze sempre maggiori, a costo di violare la legge. In diverse occasioni campioni milionari sono stati colti in un vorticoso giro di scommesse clandestine.
E naturalmente, dove scorre il danaro, si abbevera la yakuza, l’onnipresente e onnipotente organizzazione mafiosa del Giappone.
Recentemente, sapendo che le primissime file della platea sono sempre riservate agli sponsor perché sono inevitabilmente inquadrate per ore dalle telecamere della Nhk ( la televisione di Stato che trasmette in diretta tutti i tornei), la yakuza ha ottenuto che fossero tutte assegnate ai propri boss.
Un modo esplicito per dire al Paese: «Gli sponsor del sumo adesso siamo noi».
Nuvole nere si addensano su tutti i dohyo del Giappone.”
(articolo tratto da “Il Venerdì” (supplemento de “la Repubblica”), 29 Gennaio 2016, n° 1454)
Oi-cho mage: l'acconciatura rituale di un lottatore di sumo
Il nodo del pesante perizoma (mawashi) indossato durante gli incontri
La fase iniziale del match: i due lottatori si fronteggiano
Lo shiko: una mossa preparatoria dell'incontro
dove il lottatore alza una gamba tesa
fino a superare la testa
e la fa ricadere con un grande tonfo
Lo spargimento di sale ha una funzione anti-iettatoria
(cliccare sulle immagini per ingrandirle) -
.
Ci sono oggetti (ma anche cibi e comportamenti) che tutto il mondo conosce al punto da considerarli quasi stereotipi del Giappone.
Invece sono il frutto di esperienza secolare, capace di trasformare molte espressioni umane in forme d’arte e di filosofia.
Eccone alcuni esempi:Bonsai

Educare (“sai”) in un vassoio (“bon”): creare minialberi è considerata in Giappone la massima espressione dell’unione tra natura e arte, in un rapporto – in continuo divenire – che mira alla perfezione.
In un millennio di pratica è stata sviluppata un’estetica che punta su miniaturizzazione, proporzione tra gli elementi, asimmetria e assenza di ogni traccia visibile dell’artista.
Diversi gli stili che modellano le forme, dall’eretto formale (“chokkan”), che prevede un tronco drittissimo e posizione dei rami codificata, allo spezzato dal vento (“shakan”), dal boschetto o gruppo (“yose-ue”) alla cascata (“kengai”).
Ci sono bonsai mignon, alti 3-8 centimetri, difficilissimi da realizzare, e bonsai extralarge, che arrivano a due metri.
Se correttamente curati (rinvasi e potature di radici e tronchi sono frequenti), possono vivere centinaia di anni, passando di mano in mano.Katana

La spada del samurai ha lama curva con taglio singolo e lunghezza superiore ai 60 centimetri. Ha impugnatura doppia e rende meglio nei fendenti.
Forgiata a partire dal Quattrocento, ha soppiantato la “tachi”: più arcuata e di maggiori dimensioni, era l’arma fabbricata tra il XII e il XIV secolo dai maestri spadai delle cinque scuole, sorte in corrispondenza delle aree di estrazione mineraria.
A quella di Soshu/Kanagawa apparteneva Masamune (1264-1343), considerato il più grande di tutti i tempi. La leggenda narra di una sfida con Muramasa, il rivale “cattivo”, impossibile perché quest’ultimo visse nel XVI secolo.
Così come la “tachi” era accompagnata dal “tanto” (pugnale), la katana si combinava con il “wakizashi”: il guerriero non doveva mai separarsi da queste lame più corte, considerate le guardiane dell’onore (erano utilizzate per il “seppuku” o “harakiri”, il suicidio rituale).Obi

La cintura di colore, nel karate, indica l’abilità raggiunta. Quella nera è la settima e ultima (prima vengono la bianca, la gialla, l’arancione, la verde, la blu e la marrone). C’è nera e nera, però: la vera crescita, infatti, consiste nell’acquisizione dei “dan”, cioè i gradi superiori. Questo sistema, mutuato dallo judo, fu introdotto negli anni Venti dal maestro Gichin Funakoshi, fondatore della scuola Shotokan (la più diffusa) e ideatore dell’abito (“gi”), composto da giacca e pantaloni di colore bianco. Fu in questi anni che la disciplina marziale si diffuse in tutto il Giappone, arrivando da Okinawa. Sull’isola, annessa solo nel 1879, l’arte della mano vuota (questo il significato della parola “karate”) derivava dalla combinazione di forme di combattimento e autodifesa indigene e tecniche cinesi. A praticarla erano i nobili.Origami

L’arte di piegare la carta è antichissima ed è probabilmente legata alla religione shintoista (in giapponese “carta” e “divinità” si pronunciano nello stesso modo, cioè “kami”).
Uno degli origami più importanti è quello della gru, simbolo di immortalità. La leggenda vuole che chiunque ne pieghi mille vedrà esauditi i suoi desideri. A questo racconto è legata la vicenda di Sadako Sasaki, che a due anni fu colpita dalle radiazioni della bomba atomica esplosa a Hiroshima. A undici le fu diagnosticata la leucemia: per poter guarire si mise a piegare le sue mille gru, ma morì prima di terminare. Nel Parco della Pace c’è una statua che la raffigura con le braccia tese verso il cielo e una gru d’oro che spicca il volo. Ai piedi del monumento, una targa e tantissime corone di mille gru lasciate dai visitatori.Sensu

Il ventaglio protegge dal sole l’elaborato trucco, ed è un elemento importante nella danza tradizionale della quale le geisha sono maestre.
Erroneamente confuse con le cortigiane di lusso, le “persone d’arte” (questo il significato del termine) studiano per anni musica (sanno suonare diversi strumenti), canto, ballo, cerimonia del tè, “ikebana” (composizione floreale), calligrafia, vestizione del kimono e conversazione. Oggi sono poche migliaia (contro le circa 80mila al principio del Novecento), alcune vivono ancora nei vecchi quartieri loro riservati, gli “hanamachi”, il più famoso dei quali è il Gion di Kyoto (la città in cui vengono chiamate “geiko”). Sono iscritte in un albo professionale (“kenban”) che le obbliga al rispetto di regole morali ed estetiche. Sono escluse le cosiddette “onsen geisha” (“geisha delle terme”), considerate quasi prostitute.Sushi

Con sushi si intende qualsiasi piatto che comprenda riso bollito e condito con aceto di riso, zucchero e sale, accompagnato da alghe, verdure e/o pesce (cotto, crudo o marinato).
Per gli occidentali, però, è sinonimo di “hosomaki”, i rotolini di riso ripieni e avvolti nella nori, e “nigirizushi”, le fettine di “ebi” (gamberetti), “ikura” (salmone) e “katsuo” (tonno) su polpettine di riso. Si dice che questi ultimi siano stati inventati dallo chef Hanaya Yohei (1799-1858), che aprì un suo locale a Tokyo dopo un lungo apprendistato (ancora oggi per diventare maestro sono necessari almeno cinque anni al servizio di uno “shokunin”).
Sono invece un’invenzione americana i “California rolls” (“uramaki”), quei rotolini in cui l’alga avvolge il ripieno ed è circondata dal riso guarnito con uova di pesce o semi di sesamo.Kama

Il bollitore posto in una buca quadrata (“ro”) ricavata in uno dei tatami indica che la cerimonia del tè si sta svolgendo in autunno o in inverno (in primavera e in estate il “kama” è invece collocato su un braciere appoggiato sopra i pannelli rettangolari fatti con paglia di riso intrecciata e pressata).
La “cha no yu” (letteralmente “acqua calda per il tè”) – detta anche “chado” o “sado” (cioè “via del tè”) – è la più celebre della arti tradizionali zen e fu definitivamente codificata nel Cinquecento dal monaco buddista Sen no Rikyu.
Sono molti gli attrezzi necessari alla preparazione del tè (che deve essere quello verde polverizzato chiamato matcha): tra questi il mestolo in bambù (“hishaku”) e il “futaoki” (un supporto anch’esso di bambù dove viene poggiato l’ hishaku).Kimono

Il kimono (letteralmente “cosa da indossare”), l’abito giapponese per eccellenza, deriva dall’abbigliamento tradizionale degli Han cinesi, divenuto popolare in Giappone nel 700.
Modificatosi nel corso dei secoli, ha assunto la sua forma definitiva (a T, con le maniche lunghe e l’alta cintura) durante il periodo Edo.
L’abito maschile, che generalmente è di colore scuro e opaco, è più semplice di quello femminile: il primo si compone di 5 pezzi, il secondo di una quindicina.
La fascia (“obi”) è fermata in vita con diversi tipi di nodo (“musubi”) sulla schiena: anche per questo per la vestizione è necessario l’aiuto di più persone.
(Articolo tratto dalla rivista “Meridiani”, anno XXIV, Febbraio 2011, n° 195) -
.
Tanti cari auguri Maruskina!

Posts written by The Sound Of Silence |